
Il problema dei soggiorni a Dachigam era il loro effetto devastante sulla determinazione. Quel posto metteva in evidenza la futilità dell’intera faccenda. Dava l’impressione che in realtà il Kashmir appartenesse a quelle creature. Che nessuno di coloro che se lo stavano contendendo – kashmiri, indiani, pakistani, cinesi (…), e nemmeno pahadi, gujjar, dogra, pashtun, shin, abitanti del Ladakh, balti, gilgiti, puriki, wakhi, yaskhun, tibetani, mongoli, tatari, mon, khowar -, che nessuno di noi, santi o soldati, avesse il diritto di rivendicare per sé la bellezza davvero paradisiaca di quel luogo.
A più di vent’anni dal suo primo romanzo, Il dio delle piccole cose (1996), Arundhati Roy torna a catturare il lettore con Il ministero della suprema felicità. Come vent’anni fa, la scrittrice indiana è in corsa per il Man booker prize [1] – con un validissimo candidato.
Un altro romanzo, dopo una lunga pausa
Il nuovo romanzo arriva dopo una lunga pausa dalla narrativa, ma non dalla scrittura: gli anni Duemila hanno visto Roy divisa tra libri di non fiction e giornalismo militante. I suoi obiettivi erano e sono l’industrializzazione e la globalizzazione selvagge, la corsa al nucleare, la guerra e il terrorismo, il sistema delle caste, l’occupazione del Kashmir. A spiegare cosa l’abbia convinta a tornare alla fiction è stata la stessa autrice, durante un’intervista al Nourse Theatre di San Francisco[2]: «La destra nazionalista è andata al governo in India e a quel punto per me restare in silenzio è diventato un lusso che non potevo più permettermi, perché avrebbe significato approvare le loro scelte.»
E così Il ministero della suprema felicità è un libro-denuncia dello status quo; un condensato di esperienze, reso intrigante dalla forma narrativa e dalla particolarissima penna di Roy. Lo compongono tre complesse storie, con personaggi disparati che si incontrano in maniera casuale, inaspettata; come i vicoli di Delhi (le sue «rughe») e i suoi cavalcavia (i suoi «capelli» di cemento), quando senza preavviso si passa dallo scintillante quartiere “bene” alla più misera delle periferie.
Trame
Il primo focus è su Anjum, un hijra, una donna nata nel corpo di un uomo, che si scontra con un mondo che le caste e la religione dividono rigidamente in bianco e nero, senza sfumature.
Non sapeva mai quale casella spuntare, in quale fila aspettare, quale bagno pubblico usare. (…) Sapeva di essere tutta sbagliata, sempre in torto.
Il riconoscimento degli hijra ad opera della società è solo apparente, se è vero che vivono in gruppi separati. Coinvolta nel massacro di Godhra, sopravvive perché «ammazzare gli hijra porta sfortuna»: e così Anjum viene emarginata persino dalla morte.
Non-uccisa. Non-ferita. (…) Lei sola. Perché loro potessero continuare a essere benedetti dalla fortuna. Un Portafortuna per quei Macellai.
La scena successiva introduce Miss Jebeen Seconda, una neonata nerissima abbandonata tra i rifiuti e i cani rognosi che popolano i dintorni del Jantar Mantar, l’ex osservatorio astronomico, diventato punto di raccolta di una variegata umanità in protesta contro il mondo. Di padre e madre ignoti, ma figlia di un’ingiustizia, la sua misteriosa apparizione nella spazzatura è l’occasione per descrivere il caos di una strada senza regole, un’oasi di apparente libertà dal governo (in realtà le spie sono dappertutto) dove si sono concentrati gli accattoni e i poveracci cacciati dalla città per far spazio al progresso.
E poi c’è la sfuggente Tilo, innamorata di Musa (che combatte per la libertà del Kashmir) ma sposata con Naga, reporter solidamente allacciato con i servizi segreti.
Il tema della morte
Sullo sfondo, gli indù massacrano i musulmani senza pietà, la lotta tra le caste non conosce tregua o giustizia. Il Kashmir combatte ostinatamente per la sua Azad, la sua libertà; il governo tortura i traditori, mentre i ricchi sono distratti dalla pubblicità.
La morte era dappertutto. La morte era tutto. Carriera, Desiderio. Sogno. Poesia. Amore. La gioventù stessa. Morire divenne semplicemente un altro modo di vivere.
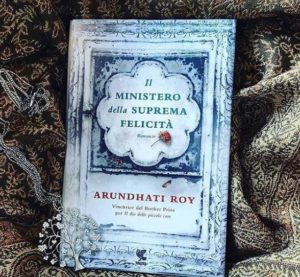 E proprio data la sua onnipresenza nella grande Storia, la Morte diventa un convitato necessario anche nelle piccole storie di cui si compone il libro; i personaggi principali de Il ministero della suprema felicità si ritrovano a vivere in un cimitero, e al tempo stesso gli danno vita. Solo quando la morte viene accettata come presenza necessaria e non più avvertita come minaccia incombente, quando la separazione tra il mondo dei vivi e quello della memoria si assottiglia, solo allora i protagonisti giungono alla serenità (senza bisogno, peraltro, di scomodare la reincarnazione).
E proprio data la sua onnipresenza nella grande Storia, la Morte diventa un convitato necessario anche nelle piccole storie di cui si compone il libro; i personaggi principali de Il ministero della suprema felicità si ritrovano a vivere in un cimitero, e al tempo stesso gli danno vita. Solo quando la morte viene accettata come presenza necessaria e non più avvertita come minaccia incombente, quando la separazione tra il mondo dei vivi e quello della memoria si assottiglia, solo allora i protagonisti giungono alla serenità (senza bisogno, peraltro, di scomodare la reincarnazione).
Lo stile e la poesia nel Ministero della suprema felicità
Come si diceva, un libro di questo tipo non si nutre di pura immaginazione: molta parte è storia, politica (sullo sfondo del romanzo aleggia il Gujarat ka Lalla, alias Narendra Modi, accusato di aver tollerato il massacro dei musulmani a Godhra, eppure asceso a ruoli di potere sempre più importanti), costume. Un lungo reportage tra le contraddizioni della sterminata India, ognuna delle quali diventa una storia, un volto, per darle concretezza e consentire al lettore di calarsi nel contesto.
Il tutto è impreziosito dallo stile di Roy: a tratti umoristico, più spesso satirico, in grado di affondare nel cuore del problema senza appesantire il discorso.
Non mancano momenti terribilmente crudi, e altri di dolcissima poesia (come la lettera di Musa alla figlioletta defunta); e dato che il tema non è dei più semplici (è una storia, non una favola) la presenza di diversi registri risulta molto utile, perché invoglia il lettore a non ritrarsi di fronte alla gravità di alcune situazioni.
«Ci sono contesti in cui solo la letteratura riesce a dire la verità. Se viaggi o vivi in Kashmir (…) non basta riuscire a produrre rapporti sulle violazioni dei diritti umani, articoli di giornale o cataloghi di morti e scomparsi. La letteratura invece può raccontare cos’è davvero il terrore: quello delle persone terrorizzate e quello delle persone che terrorizzano, il terrore dei soldati e quello delle persone che non sanno se i loro figli torneranno a casa domani.» [2]
Bentornata, Roy.
-
- Titolo: Il ministero della suprema felicità (The ministry of the utmost happiness)
- Autore: Arundhati Roy
- Genere: Romanzo
- Filone letterario: Letteratura indiana
- Traduzione: Federica Oddera
- Casa editrice: Guanda
- Anno di pubblicazione: 2017
[1] Articolo scritto a inizio settembre. Il libro non è entrato nella Shortlist.
[2] Le citazioni di questa recensione sono tratte da un articolo di Giovanni De Mauro, «Internazionale», 25 agosto 2017, pag. 5
Questa recensione è stata scritta per Critica Letteraria

Pingback: Viaggio tra le contraddizioni dell’India: il ritorno di Arundhati Roy, tra Storia e piccole storie – unlibrounvolo